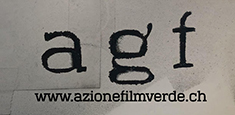Il "nuovo cinema ticinese" in programma a settembre al cinema Xenix di Zurigo
La rassegna "Ticino Cinema", presentata nel mese di settembre 2022 al Kino Xenix, accende i riflettori sulla nuova ondata creativa della scena cinematografica ticinese attraverso la proiezione di film legati al Ticino degli ultimi anni, incontri e proiezioni speciali.

Grafica di Nicole Barbieri.
Durante il mese di settembre 2022, il Cinema Xenix a Zurigo - spazio per gli amanti del cinema e un importante punto d'incontro per la vivace cultura cinematografica zurighese - presenta la rassegna "Ticino Cinema", dedicata al cinema indipendente in Ticino. Regione che nell'ultimo decennio ha visto una crescita senza precedenti della sua produzione cinematografica. "La sensazione è quella di trovarsi di fronte a una rinnovata ondata di energia creativa, che promette di non esaurirsi tanto presto", commenta il regista e sceneggiatore ticinese Francesco Rizzi, autore dell’introduzione al programma che riportiamo in coda alla news. La rassegna, che vede la collaborazione della Ticino Film Commission, sarà completata da due serate speciali.
Il programma completo delle proiezioni è disponibile sul sito web del cinema Xenix.
EVENTI SPECIALI
Giovedì 8 settembre 2022
Ore 18:30 - Un incontro per discutere dell'attuale scena cinematografica ticinese con i cineasti ticinesi: cosa ha portato a questa rinnovata energia nella scena cinematografica? Quali sono le opportunità e le sfide del cinema in Ticino oggi? Che ruolo ha la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana RSI, come nascono le coproduzioni con l'Italia, che ne è della reciprocità? E qual è il significato del rafforzamento del legame Ticino-Zurigo?
Gli ospiti della serata moderata da Jenny Billeter (programmazione, co-direzione Kino Xenix) saranno:
- Niccolò Castelli (regista, direttore artistico delle Giornate di Soletta, direttore della Ticino Film Commission)
- Alessandro Marcionni (responsabile Doc & Fiction, RSI)
- Olga Lamontanara (produttrice Cinédokké e Amka Films)
- Antonio Prata (distributore Noha Film, regista)
- Klaudia Reynicke (regista)
Seguirà un rinfresco con prodotti ticinesi per il quale ringraziamo sentitamente Ticino Wine.
Ore 20:45 - Proiezione del film SEMRET con l'introduzione della regista Caterina Mona.
Giovedì 15 settembre 2022
Ore 20:00 - Presentazione in anteprima per la Svizzera tedesca del film ZAHORÍ alla presenza della regista Marì Alessandrini.
INTRODUZIONE AL PROGRAMMA
"Nuovo cinema ticinese" di Francesco Rizzi
Nell'ultimo decennio, il piccolo mondo del cinema indipendente ticinese ha assistito a una proliferazione di nuove voci, favorita da una vitalità e da una continuità nella produzione che raramente si sono viste in passato. Diversi film hanno ricevuto riscontri positivi e la sensazione è quella di trovarsi di fronte a una rinnovata ondata di energia creativa, che promette di non esaurirsi tanto presto.
Non si tratta di “scuole” o movimenti, ma del frutto degli sforzi profusi da spiriti coraggiosi e intraprendenti che hanno messo in comune le loro esperienze, la loro passione e continuano a creare connessioni all'interno del Ticino stesso, ma anche con il resto della Svizzera e con l'estero.
In un Cantone che per sua natura si trova ogni giorno al centro di grandi flussi e scambi fra persone e culture diverse, questa apertura alla contaminazione rappresenta una risorsa preziosa. Una ricchezza che si riflette nella diversità di vissuti, sguardi e storie che il cinema di produzione ticinese propone oggi, affrontando con creatività l'esiguità dei mezzi e con sempre meno paura le proprie peculiarità.
Nell'itinerario che segue, proverò a far emergere alcune possibili connessioni tra i film di questo programma.
Nel mio Cronofobia, un uomo misterioso si aggira a bordo di un anonimo furgone. Osserva una donna, che vive come congelata nei luoghi e nei ricordi di un mondo che non le appartiene più. A unirli, un sottile senso di angoscia per il tempo che scorre, come dentro una prigione.
In Love Me Tender di Klaudia Reynicke, l'agorafobia blocca Seconda dentro la casa dei suoi genitori. Persi i pochi contatti famigliari e con il mondo esterno, la donna può contare solo sulla sua disperata sete di libertà... e su una tuta blu.
In Atlas di Niccolò Castelli, Allegra sorride e scherza sulla cima di una montagna, circondata dagli amici con cui l'ha scalata. Allegra è sola in bagno, davanti allo specchio osserva le profonde cicatrici sul suo corpo. Tra i due momenti, un abisso. La vita che cambia in un attimo, mettendoci a confronto con la paura per ciò che è lontano da noi.
Tre film che, in modi e toni diversi, riflettono sull'isolamento e sul suo superamento. Ritratti di personaggi ribelli, rinchiusi nei loro mondi fatti di gabbie reali o mentali, nella tensione a lungo sedimentata di un dolore sordo, che non può trovare conforto nelle parole, ma che cerca invece lo sfogo in un'ossessiva ritualità di gesti: le silenziose simulazioni di intimità dei protagonisti di Cronofobia; le curiose danze dai movimenti scomposti di Seconda in Love Me Tender; i ripetuti, dolorosi esercizi di arrampicata di Allegra in Atlas. Tre drammi psicologici sorretti da prove attoriali di notevole complessità. Tre storie di 'guarigione', che cercano una verità dei sentimenti lontano dai sentimentalismi e dai cliché.
Lontano dai luoghi comuni romantici, in questo caso del Ticino bucolico e rurale è il documentario Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto di Aldo Gugolz, che ci consegna l'intenso ritratto, fra luci e ombre, pioggia e nebbia, di un giovane contadino della valle Onsernone, che ha ereditato i propri valori da un padre hippy svizzero-tedesco, insieme a un alpe su cui produrre formaggio. Dovrà confrontarsi con la selvaggia bellezza e la durezza della vita di montagna, al cui richiamo è difficile resistere, nonostante i debiti, l'arrivo di un figlio e un angosciante caso criminale che lo vede indirettamente coinvolto.
Un curioso ibrido fra documentario e detective story è pure Moka Noir, in cui il regista Erik Bernasconi -non senza una certa ironia- veste i panni del classico investigatore hard boiled e ci accompagna fra i paesaggi di archeologia industriale di Omegna, in alto Piemonte, per tentare di risolvere un caso: chi ha ucciso quella che durante il boom economico italiano del dopoguerra era la più fiorente manifattura europea di piccoli elettrodomestici? I lavoratori? Gli imprenditori? La politica? Immerso in immagini di un bianco e nero contrastato, il detective interroga testimoni e si aggira per le immense fabbriche abbandonate come se fossero scene del crimine, alla ricerca di indizi per spiegare la grande crisi che negli ultimi decenni ha svuotato di identità un'intera comunità.
A volte i cineasti ticinesi cercano fuori dal loro territorio delle storie che rispecchino le loro intuizioni, o che permettano loro di confrontarsi con una parte delle proprie radici culturali o famigliari. È quest'ultimo il caso di un autore 'nomade' come Daniel Kemény, che in Sòne: ci porta nel piccolo villaggio della sua infanzia, Pietrapaola, arroccato attorno a un'imponente rupe nella Calabria più profonda. Anche qui - come in Moka Noir - si tratta di raccontare un luogo moribondo, che sta scomparendo. Daniel sceglie di farlo attraverso la musica, vera voce e memoria del borgo, mettendo in scena se stesso e gli altri abitanti in una rappresentazione vitalistica e insieme astratta, ricca di suggestioni di una poesia surreale.
Anche Stefano Knuchel si mette in scena per affrontare un ricordo, per fare i conti coi luoghi e le persone che hanno segnato il suo vissuto. In Quando ero Cloclo racconta le avventure della sua famiglia di inguaribili sognatori, capitanata da un padre in perenne fuga dalle responsabilità e dalla polizia. Il regista abbraccia affettuosamente l'eccentricità dei personaggi e descrive una realtà spesso drammatica con pennellate oniriche, e uno sguardo permeato di umanità e di un dolce senso di nostalgia. Un atto di riconciliazione con i propri fantasmi, attraverso il cinema.
Il cinema ticinese è fatto dell'arte di trovare immagini evocative, ricavando il massimo da pochi elementi. Ad Alessio Pizzicannella, in Dawn Chorus, bastano quattro ragazzi su una strana isola lacustre, con una villa e un giardino tropicale da cui si intravvedono le cime innevate delle montagne, per dare vita a un film intrigante, immerso in atmosfere liminali, fra sospensione e rivelazione.
Monsieur Pigeon di Antonio Prata ci invita a conoscere Giuseppe, il dio dei piccioni. Lo incontriamo in una via di Beaubourg, a Parigi, mentre si ferma a nutrire gli uccelli e si prende cura di loro. Questo piccolo film ha la stessa preziosa sensibilità del suo protagonista: uno sguardo d'amore e compassione per ciò che è marginale, giudicato inutile e mal tollerato.
Giudizi sommari e semplificazioni non trovano spazio in Barbara adesso di Alessandra Gavin-Müller, che inscena il dramma di una madre senza istinto materno. Barbara è distesa in un bosco di betulle, cerca l'abbraccio della Natura, la grande madre. Sua figlia sta crescendo lontano da lei. Barbara ha preso decisioni coraggiose per tentare di risolvere un lacerante conflitto.
Molti film propongono riflessioni sul rapporto con la Natura. L'affascinante Zahorì di Marì Alessandrini è una specie di strano western ambientato nelle steppe di Patagonia, in cui l'adolescente svizzero-italiana Mora rifiuta un approccio di vita 'colonizzatore' o utilitaristico e cerca un radicamento più in armonia con la natura selvaggia, come quello dei gauchos.
Sulle rive svizzere e italiane del fiume Ticino, Tutto l'oro che c'è di Andrea Caccia documenta un microcosmo di uno splendore che si fa sempre più rarefatto, in cui l'uomo è solo un ospite timido, per lo più rispettoso, e le uniche vere voci sono quelle primordiali delle acque, del vento e degli animali.
Alle prese con la natura selvaggia sono anche le protagoniste di 40enni in salita, commedia avventurosa di Bindu De Stoppani. Un percorso di montagna irto di ostacoli si fa metafora delle asperità nei rapporti fra vecchie amiche che non si vedono da tempo, in un racconto sulla riconquista di solidarietà fra donne.
Restiamo in alto, su una celebre collina sopra Ascona, con il dramma di produzione svizzero-tedesca Monte Verità di Stefan Jäger, che ci riporta indietro ai primi del '900 per vivere una storia di emancipazione femminile sorprendentemente moderna, che è anche una ricostruzione storico-culturale dello spirito di un luogo fra i più mitici del Ticino.
E parlando di miti è difficile sfuggire al Gottardo, già al centro in passato di una pagina fondamentale del cinema ticinese. Una massiccia barriera naturale, ma anche punto di passaggio per riunire diverse anime della Svizzera, come nel caso dei membri dell'omonima band ticinese -anch'essa mitica-, che si racconta nel bel documentario di Kevin Merz Gotthard - One Life, One Soul.
Oltrepassate le Alpi, concludiamo approdando infine a Zurigo con il recentissimo Semret di Caterina Mona, sensibile ritratto di una giovane madre eritrea in lotta per difendere i propri diritti e tutto ciò che ama.
Mentre il cinema attraversa cambiamenti importanti, l'auspicio è che questo fermento ticinese possa resistere, continuando a proporre storie appassionanti e ad esplorare le proprie particolarità con l'immutata voglia di sorprendere il pubblico.